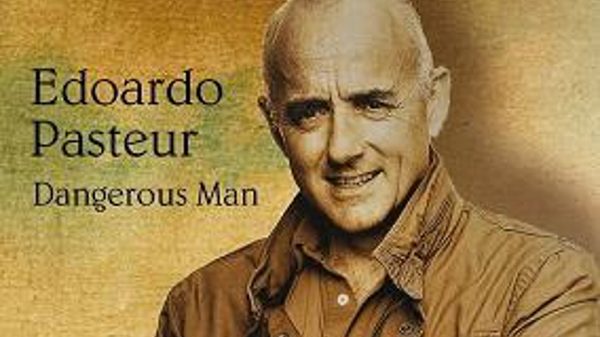Quinta puntata della rubrica “chitarre rock”, con cui si va a ricomporre il trittico sacro della chitarra rock di matrice inglese.
Nelle scorse settimane su queste pagine si è fatto cenno più volte ai leggendari Yardbirds e ai loro non meno leggendari chitarristi solisti.
Come si è visto, Jeff Beck e Jimmy Page avevano dato dei contributi fondamentali all’evoluzione dello strumento ma, come ricordato fino alla nausea negli approfondimenti precedenti, lo spettro con cui loro – e tutti gli artisti di quegli anni – avrebbero dovuto fare i conti, aveva un nome e un cognome: mr Eric Clapton. Anche se la sua identità sarebbe stata nascosta più volte dietro epiteti, soprannomi, apparizioni in studio fugaci – che sia “l’angelo misterioso” dell’album bianco dei Beatles, il Derek nato con i Delaney & Bonnie, il tanto acclamato Slowhand o addirittura l’esaltazione a creatura ultraterrena che vedeva la sua celebrazione sui muri di Londra: “Clapton is God” – la voce della sua chitarra ha avuto, e continua ad avere, un timbro inconfondibile, scrivendo alcune delle pagine più belle ed emozionanti della storia della musica del Novecento.
Figlio di una ragazza madre, cresciuto con l’illusione che i nonni fossero i genitori, deriso e maltrattato dalla società inglese e i suoi strascichi di puritanesimo, Clapton deve tutto alla sua chitarra, l’unico scudo che lo avrebbe protetto da un’infanzia difficile, un’adolescenza ribelle e una vita piena di dolore, dipendenze varie e lo spettro della morte più volte a bussare drammaticamente alla sua porta. Ma non siamo qui a tracciare il profilo psicologico di un’artista che nel blues, nudo e crudo, ha trovato la sublimazione della mancanza di un padre, di una stabilità famigliare, di un figlio…
Certo è che Freddie King e Robert Johnson su tutti, ma anche Albert e BB King, l’amicizia e ispirazione reciproca con Buddy Guy, l’amore incondizionato per Lead Belly, Howlin Wolf, Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, Big Bill Broonzy – artisti di cui il giovane Eric ignorava il volto e il colore della pelle ma amava la voce – hanno inconsciamente forgiato il genio di quello che per molti è considerato, ancora oggi, come “il chitarrista per eccellenza”.
Dopo qualche difficoltà iniziale con la chitarra classica, le piccole e deboli mani del giovane Eric si trovarono subito a proprio agio con le sei corde, ben più morbide, della chitarra elettrica. E i risultati arrivarono prestissimo, già sul finire degli anni Sessanta il suo nome era leggenda. A differenza di quanto avvenuto per molti altri guitar heroes, per lui il successo sarebbe arrivato nell’immediato, dopo le prime apparizioni dal vivo e in studio, pur non essendo né un frontman, né (non ancora, perlomeno) un cantante. All’inizio dei Settanta Clapton era già acclamato in tutto il mondo. Oltre ad aver reso famosi in Inghilterra gli Yardbirds, piegò la dura personalità di John Mayall (il padrino del British Blues) al suo sound; i Rolling Stones lo vollero come chitarrista solista al posto di Brian Jones (Clapton rifiutò ma partecipò alle registrazioni di Sticky Fingers); fu l’unico artista esterno alla band al quale i Beatles avrebbero concesso i crediti in un loro disco; con i Cream, insieme a Ginger Baker e Jack Bruce, fondò il primo supergruppo della storia del rock; Jimi Hendrix accettò di andare in Inghilterra solo per avere il privilegio di suonare con “il professore” (così lo chiamava) e aveva alle sue spalle un seguito, più o meno forzato, di emulatori ed estimatori.
Come è evidente, poco più che ventenne, Clapton si era già imposto sull’intero panorama musicale underground e non solo. Potremmo affermare addirittura che il ruolo centrale che avrebbe acquistato la figura del chitarrista solista all’interno dei vari gruppi, nati degli anni a seguire, sia proprio il frutto del fenomeno Slowhand. Fino a pochi anni dall’arrivo di Clapton infatti, il chitarrista era considerato uno strumentista come tanti, ed era soltanto il frontman ad attirare su di sé le luci dei riflettori. Le cose cambiarono proprio quando, sul finire del 1965, Eric decise di abbandonare gli Yardbirds.
A detta sua: “odiavo i riflettori, e tutto quel pop mi deprimeva”. La sua improvvisa dipartita dal gruppo, con il pubblico che reclamava a gran voce il suo nome, portò un desiderio nuovo negli spettatori che, avidamente, avrebbero cercato con le orecchie qualcosa in più di una semplice chitarra ritmica. Forse per avere un termine di paragone con Eric, forse perché si sentivano orfani di un suono che era già diventato fondativo di un’intera generazione musicale. E probabilmente anche quella sua – del tutto casuale – arte di scomparire e riapparire in varie vesti, forme sonorità, avrebbe reso questo meccanismo ancor più forte.
Infatti, quando nel 1966 John Mayall lo accolse tra le sue braccia, con i Blues Breakers avrebbe inciso un album di cover – Blues Breakers with Eric Clapton – che sarebbe stato il disco di maggior successo di sempre per la formazione inglese, plasmando il suono dei numerosi grandi chitarristi che di Clapton avrebbero preso il posto dopo la sua improvvisa ed immediata dipartita.
Eric lasciò Mayall nello stesso anno, dopo un solo fondamentale lavoro in studio. Se ancora oggi quel disco, pur essendo un po’ desueto dei suoni come nel mixaggio, stabilisce perfettamente i canoni della chitarra blues moderna, gli stessi Peter Green e Mick Taylor con John Mayall avrebbero dovuto fare i conti con il suo sound, così come già anche Jeff Beck e Jimmy Page negli Yardbids. La Les Paul delle sue versioni di “Hideaway” o “All You Love”ha fatto scuola e ha imposto in nuovo modo di suonare.
In quegli stessi anni anche il mondo dell’industria musicale iniziò a mostrarsi non indifferente al fenomeno in divenire. Il grande vate della Atlantic Records Ahmet Ertegün ricorda: “ero in un club, e davo le spalle al palco. Sentii quel suono della chitarra, sembrava BB King, quando mi voltai vidi quel bellissimo ragazzino sbarbato suonare con gli occhi chiusi”.
Di lì a poco sarebbe diventato God. Nel 1966 infatti, il destino volle che i tre solisti più importanti della scena musicale inglese – al basso Jack Bruce, alla batteria Ginger Baker e alla chitarra lo stesso Clapton – si unissero per formare quella che Hendrix avrebbe definito “la sacra crema del rock”, erano nati i Cream.
E probabilmente, con loro, nacque anche l’hard rock, o perlomeno le fondamenta erano ben fissate. Suoni distorti, utilizzo del wah wah, lunghe improvvisazioni, il power trio proponeva un modo del tutto nuovo di avvicinarsi alla musica, decostruendo la canzone stessa, riprendendo semplici strutture del blues e portandole verso atmosfere psichedeliche e liberatorie fino ad allora inesplorate.
Erano gli anni della swinging London e ben presto il successo di pubblico portò in alto nelle classifiche i dischi della nuova formazione. Disraeli Gears appare ancora oggi come il manifesto di un cambiamento in divenire di un’intera generazione musicale. Il suono di Eric, a questo punto, era ben definito: massiccio, con un grande attacco ma anche caratterizzato da una profondità inconfondibile. Fu rinominato il “woman tone”, Clapton otteneva questo particolare suono dalla sua Gibson Sg colorata a tinte psichedeliche, chiudendo i toni dei pickup, spingendo al massimo il suo Fender Bluesbreaker e, talvolta, utilizzando selvaggiamente quel wah wah, che poi sarebbe diventato il trademark di Jimi Hendrix.
La Jimi Hendrix Experience, non a caso, sarebbe stata un trio, proprio come lo erano stati i Cream. In quegli stessi anni, sotto lo pseudonimo di “Angelo Nero”, Eric avrebbe scritto e registrato il solo di “While My Guitar Genly Weeps” per il White Album dei Beatles, capolavoro assoluto nonché altra tappa fondamentale per chiunque voglia avvicinarsi alle sei corde. C’è l’intera dimensione Slowhand in quei fraseggi: il playing passionale ma rilassato, la classe cristallina, un suono molto fisico ma comunque privo di impurità, ma soprattutto il vibrato, quel suo vibrato inimitabile.
E fu così che “Il pubblico cominciò a idolatrarlo, e questo gli dava fastidio. Andò su tutte le furie quando lesse su un muro la scritta ‘Clapton è Dio’”, il divismo si era improvvisamente incollato sulla sua figura schiva e silenziosa. Dopo la breve avventura con una nuova formazione, i Blind Faith, insieme a un’altra leggenda, Stevie Winwood; per la prima volta nella sua carriera Eric avrebbe fatto perdere le tracce di sé. Infatti, all’inizio degli anni Settanta abbandonò i clamori di una Londra che lo chiamava a gran voce per percorrere in bus, in lungo e in largo, l’America del nord con i Delaney & Bonnie, formazione country rock ben lontana dal glamour verso cui si stava avvicinando il mondo dell’hard rock e dei supergruppi. Furono gli anni in cui Eric si appropriò di nuove sonorità, avvicinandosi al folk, al southern rock, a Bob Dylan e, soprattutto, a The Band. “Ascoltai Music From Big Pink, e cambiarono la mia vita” avrebbe ricordato in più occasioni.
Nel 1970 Clapton avrebbe inciso quello che probabilmente è il suo capolavoro Layla and Other Assorted Love Songs. Un disco blues nel suono come nell’indole, nella scaletta come nell’anima che lo aveva generato. La maggior parte delle canzoni blues parlano di donne andate, amori impossibili e sofferenze senza fine. La Layla di Clapton, che di lì a poco avrebbe sposato, era Pattie Boyde, moglie di un altro grande musicista, nonché grande amico di Eric: George Harrison. Clapton incise quel disco in una manciata di sessioni con la sua nuova band, si diede uno pseudonimo, Derek, e i Dominos erano i suoi compagni di viaggio, molti dei quali avevano abbandonato i Delaney & Bonnie per seguirlo. Per l’incisione in studio avrebbe portato con sé anche quello che lui considera – ancora oggi – come il più grande chitarrista slide di sempre, il “Free Bird” Duane Allman. Il disco è un esempio magistrale di commistione di più atmosfere musicali: il british blues, il country rock, la tradizione southern, ed è la prima grande prova di Clapton accanto alla chitarra della sua vita, la Fender Stratocaser.
Con Brownie (il nome della chitarra che avrebbe utilizzato per diversi anni) sono stati immortalati momenti indimenticabili come quelli di “Nobody Knows You When You’re Down and Out” o “Have You Ever Loved a Woman”, oltre che i duetti funambolico con la slide guitar di Allman in “Anyday” o “Why Does Love Got to Be so Sad”. La tradizione suddista ha avuto un grandissimo influsso sul suono di Clapton in questa fase, ben meno ampolloso di quello costruito con i Cream, molto più secco e viscerale, con pennate violente e molto nette.
L’esperienza americana mostrerà una caratteristica fondamentale per la crescita artistica del chitarrista: la capacità di rielaborare il proprio sound e modo di suonare metabolizzando e assorbendo le influenze dei numerosi artisti con cui avrebbe collaborato.
Purtroppo, però, neanche la lontananza dai riflettori londinesi avrebbe dato pace all’animo tormentato del bluesman inglese. La dipendenza dall’eroina, sviluppata ai tempi dei tour con i Delanie & Bonnie, la morte dell’amico/rivale Hendrix (con i Derek and the Dominos aveva registrato in suo onore una cover di “Little Wing”), i problemi sentimentali, il pubblico affamato di concerti e hits, spinsero Clapton verso un autoisolamento da cui non sarebbe riemerso fino al 1973, grazie all’amico Pete Townshend. L’evento in suo onore, il “Raimbow Concert”, rappresentò un punto di svolta per la carriera – nonché per la vita stessa – dell’artista britannico. In quel concerto, oltre a Townshend, furono presenti nomi tutt’altro che scontati come Ronnie Wood e Stevie Winwood, convinti che solo tramite la musica Eric avrebbe potuto salvarsi.
Il 1974 infatti sarebbe stato l’anno del suo vero e proprio primo lavoro solista, il primo di una serie di dischi di successo e tour infiniti e memorabili. È un Clapton nuovo, vincitore della sua personale battaglia contro l’eroina, sconfitto però in quella contro l’alcol, e la sua vicenda personale, da vero bluesman si ripercuote inevitabilmente sul suo sound. L’esplosività e la verve provocatoria dei suoni distorti sono quanto di più distante dal suo chitarrismo in quella fase, e l’elemento folk inizia a prendere il sopravvento su quello tipicamente rock, lontani anni luce sembrano ormai gli anni degli esordi con i supergruppi britannici. Molti pezzi acustici, ballands bellissime e romantiche, un uso della chitarra elettrica – l’amata stratocaster nera Blackie – sempre più minimale ma ragionato.
In questo periodo risente moltissimo di nuove atmosfere sonore, si innamora del “tulsa sound” di JJ Cale e si lascia influenzare da atmosfere più esotiche come quelle del reggae. Tra le molte tracce di “461 Ocean Boulevard” infatti, sarebbe stata incisa una delle cover rese più famose da Eric Clapton: il classico di Bob Marley I Shot The Sheriff. I dischi in studio sono dei veri e propri gioiellini, delle perle da gustare immergendosi in una dimensione sonora fortemente umana, degli inni alla vita che spesso hanno il sapore di ancora di salvezza.
Il blues però, come sempre, non sarebbe mancato nella sua vita artistica. Infatti, si poté ascoltare, tra il 1978 e il 1983, un nuovo Clapton sound molto più vicino alla tradizione nera, con esecuzioni fulminee e brillanti e una pasta sonora distante dal “woman tone” degli anni Sessanta ma decisamente riconoscibile. Bending tiratissimi, armonici artificiali, vibrati nevrotici e tanta classe, era il repertorio di un Clapton funambolico che nei concerti non si risparmiava.
Tuttavia, forse per fuggire l’incubo di essere il “God”, l’idea di rockstar da cui voleva tanto fuggire, cercava costantemente di stemperarlo il suo virtuosismo. Infatti, dopo un bel solo di dieci minuti, preferiva defilarsi cantando e limitandosi alla ritmica con chitarra acustica, lasciando al chitarrista di spalla il ruolo da solista (e spesso le spalle erano di assoluto livello, come per esempio Albert Lee). Se l’influenza di Dylan, The Band e anche degli Stones più pacati si può avvertire come predominanti in un disco come No Reason to Cry– al quale contribuirono anche Ronnie Wood, Rick Dango e Dylan stesso con canzoni meravigliose come “All Our Past Times”, “Hello Old Friend” e “Sign Language” – l’impostazione “tulsa oriented” lo avrebbe guidato verso uno dei dischi di maggior successo – forse il più famoso – che sarebbe stato pubblicato nel 1977. Slowhand, con ironico riferimento a uno dei tanti epiteti affibbiatigli, è un piccolo grande capolavoro. Famosissime le cover (proprio di JJ Cale) di “Cocaine” e “After Midnight”, perfetta espressione della capacità di unire la propria esperienza e il proprio tocco personale, ai gusti e le influenze che più avvertiva come predominanti in quella fase.
Gli anni Ottanta si prospettano raggianti per Clapton, anche grazie a un ritrovato appeal con il pubblico, sebbene lui continui “a guardare la luce dell’uscita di emergenza durante i concerti, mi fa sentire potenzialmente libero”. Sono i giorni in cui sarebbe nato un altro grande sodalizio artistico, quello molto fruttuoso, in termini di vendite, con Phill Collins come produttore. Purtroppo, quelli furono anni di lavori mediocri, come August, salvati soltanto dalla mano sempre più matura e sempre più cristallina di slowhand e da rare eccezioni come Money And Cigarettes.
Dopo composizioni posticce e di cattivo gusto – che talvolta avrebbero macchiato una carriera altrimenti impeccabile – saranno gli anni Novanta a mostrare nuove grandi prove di Clapton. Il blues torna al centro della questione e, di nuovo, probabilmente, sarebbe stata la sua vicenda privata a riportare Eric prepotentemente verso queste sue radici. In un tragico pomeriggio dell’agosto del 1991, la tragedia della morte di Conor, il figlioletto di appena quattro anni, (leggi l’articolo) condurrà Eric ad annegare in un nuovo baratro. Scompare, nuovamente, per poi tornare in una veste nuova distante da quella patinata e cotonata degli anni Ottanta, ben lontana da quella scanzonata e dannata dei Settanta.
Quando in diretta tv su MTV Eric proporrà un concerto – divenuto poi disco – Unplugged, si presenterà in una sobria e perfetta tenuta da bluesman, una nuova reincarnazione di Robert Johnson di cui canterà e suonerà in modo mirabile alcuni classici. Clapton scava nel suo passato, ripercorre la sua storia, riarrangia sé stesso, come spesso è riuscito a fare con canzoni di altri, quasi come se il suo sé di ieri fosse un’altra persona. Il ricordo recente però è ben presente: Tears in Heaven dedicata figlioletto Conor è una delle canzoni d’amore più strazianti e commoventi mai scritte da un artista, con una chitarra e una voce di una dolcezza disarmante intrisa di malinconica rassegnazione.
Di nuovo, pur non volendo, pur mettendo sul palco l’ennesimo suo dramma privato, Clapton avrebbe fatto tendenza. Infatti, moltissimi artisti (dai Nirvana a Paul McCartney) avrebbero riproposto la formula “unplugged” da cui però Eric si era già distaccato. Nel 1994 uscirà From The Cradleed è un capolavoro assoluto. Un disco, il primo nella sua carriera, totalmente blues e fortemente elettrico. Nessuna contaminazione, solo brani tradizionali con la sua chitarra e la sua voce a fare da padrone. Quando l’intero mondo della chitarra si stava dirigendo verso il virtuosismo smoderato e ricco di orpelli, Eric si mostrò fedele alla tradizione, filtrata dal suo tocco inconfondibile, riuscendo a mantenere in vita un genere che sembrava sempre meno praticato.
I dischi successivi alterneranno buone prestazioni a capolavori totali, come testimonia benissimo l’album estratto dalla reunion del 2005 con i Cream. Il live è sempre stata la dimensione in cui Eric ha dato il meglio di sé e ancora oggi, nonostante il tempo scorra veloce e inesorabile anche per God, nonostante i problemi fisici, nonostante il suo animo (forse) rappacificato abbia spento quella sofferenza che faceva vibrare così forte le sue corde; assistere a una sua esibizione vuol dire essere di fronte al “più nero dei bianchi”, a Slowhand, a Derek, a l’angelo nero o semplicemente al più grande chitarrista di tutti i tempi.
“Still his guitar gently weeps”.