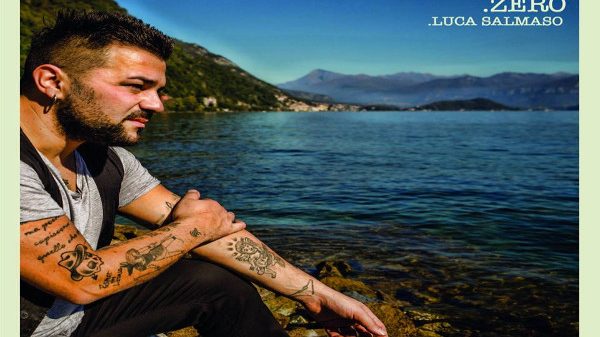Nel marzo di questo anno scorrevo i tanti articoli che sia in rete che su cartaceo commentavano la morte del cantautore americano Scott Walker.
Al di là delle tante sovrapposizioni (Teen Idol nei 60, figura di culto, recluso, ispiratore di Bowie ecc..) e oltre al dolore per una perdita importante per il mondo della musica, mi ha assalito un dubbio sintetizzabile in una semplice domanda: e ora?
Sì, perché la dipartita di Noel Scott Engel (questo il suo vero nome all’anagrafe) lascia un vuoto difficilmente colmabile. Quello che si suol dire in certi casi, ma che in questa occasione suona un po’ più vero. L’avamposto ai margini dell’Impero (quello discografico, artistico ecc.) occupato da Walker infatti era quanto di più singolare, anzi unico che sia dato di riscontrare. Come un novello Kurtz esiliato in un altrove che non era solo fisico ma anche spirituale, registrava i suoi incubi cubisti che rilasciava a cadenza decennale. Un “altrove” che abitava e lo abitava; solo lì poteva scrivere e lasciar prosperare il suo particolare genio.
L’attesa sempre più lunga tra un disco e un altro e il desiderio di seguire la propria ispirazione rigettando logiche commerciali, sono scelte che segnavano una distanza marcata con coloro che vogliono l’artista sempre connesso, sempre presente sulla scena nonostante la mancanza di reali contenuti o significati da comunicare. Il suo posto era quello dell’osservatore, dell’occhio che guarda e riporta, il tutto filtrato ovviamente dalla sua singolare sensibilità. Nelle ultime opere soprattutto, le più ostiche, le immagini della storia del Novecento, i fantasmi del Novecento, si riavvolgono veloci contro corpi tesi in spasmodica danza. L’eterno ritorno del Rimosso va a frantumarsi nel fondo di abissi Gigeriani.
Impossibile in un breve articolo tentare di ripercorrere le fasi di una vita e di una carriera artistica che può essere paragonata solo a quella dell’allievo Bowie. Tanti sono stati i cambi e le mutazioni lungo la via. Per farsi un’idea degli ultimi lavori, così geniali ma anche così distanti dalla grazia apollinea dei primi album, si pensi a una creatura musicale che ha ai propri estremi un Jeff Buckley con voce da crooner e un gruppo estremo e “rumorista” come i Sunn O))). (Band con cui tra l’altro collaborò per un disco congiunto nel 2014)
Per ricordare questo “giovane Schubert travestito da Van Morrison” (mirabile definizione di Eddy Cilia che inquadra bene lo Scott dei primi album) ho scelto di parlare di Scott 3. Per innamorarsene basta immergersi nei suoi solchi senza preconcetti di sorta: una nube di malinconia aleggia ovunque, una santa tristezza e ad ogni passo si scorgono sentori di divino Si comincia con “It’s Raining Today”: fissità d’archi che ha fatto scuola e una voce che si fa strada immobile fra ricordi lontani. Subito dopo la meraviglia di “Copenaghen”, una brezza estiva nel cuore d’inverno. Il terzo diamante nonché capolavoro del disco è “Rosemary” uno dei tanti ritratti di donna che hanno fatto capolino nel canzoniere Walkeriano.
La voce si staglia gelida fra folate di archi finché veniamo trasportati da un afflato pop a vette di piacevolezza melodica che conoscono pochi eguali.
E poi in ordine sparso arrivano, lo stupore bambino di quella scheggia di eterno (poco più di un minuto e trenta) che risponde al nome di “Butterfly”, la mestizia senza rimpianti dei due “Ragged Soldier” che sul finire della loro esistenza seduti a una panchina confrontano le proprie solitudini. Per un attimo si spalanca l’abisso (ascoltare l’intro per credere) ed è “Big Louise” tutta arpeggi sospesi e ricami di orchestra.
La cavalcata di “We Came Through” viene a spezzare il languore delle tracce precedenti e così fa poco dopo il breve frammento acustico di “30th Century Man” (Sono l’unico che in quel giro di acustica avverte presagi degli Oasis di Wonderwall?). A suggellare il tutto e sorta di addio al passato prossimo, tre eccellenti riletture del canzoniere Breliano, interpretazioni ancora una volta sentite e personali. Dall’ intensa “If You Go Away” alla giocosa (si fa per dire) “Funeral Tango” fino alla commovente “Son of …”.
Un sottile filo invisibile lega questo disco a quello che sarebbe seguito decenni dopo, ma per il momento il pubblico ancora applaude. A noi che siamo ancora qui in ascolto cosa resta? Solo questi frammenti di infinito, vertigini intraviste in sogno e tradotte in musica che giungono distanti come la luce di una stella morente ma che ancora continua a brillare.
Antonio Sebastianelli