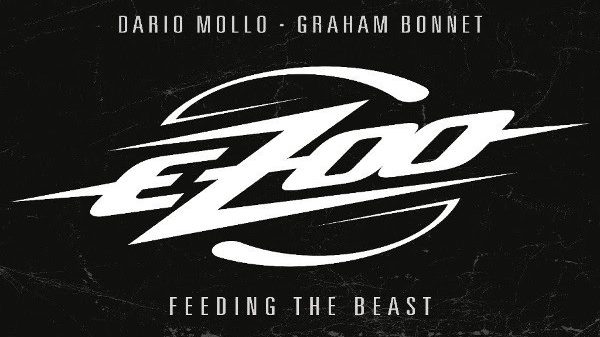Nel 1970, dopo l’uscita del fondamentale “Deep Purple In Rock”, la band britannica è sulla cresta dell’onda; la situazione che oggi ci appare assolutamente fluida nel susseguirsi cronologico degli avvenimenti che vanno dal british blues alla nascita dell’hard rock e alla sublimazione di quest’ultimo nell’heavy metal, allora è molto meno definita.
I Deep Purple vengono da una serie di dischi in cui le atmosfere sono mutate profondamente, dalla psichedelia venata di prog dell’esordio “Shades of Deep Purple” all’esperimento sinfonico con l’Orchestra di Londra, fino a “In Rock”, caposaldo dell’hard. Ma la band è reduce anche da un importante cambio di formazione: Evans e Simper, cantante e bassista, hanno lasciato il posto a Ian Gillan e a Roger Glover. Allora i ragazzi non lo immaginano, ma è nata la cosiddetta MkII, la formazione che porterà la band inglese dritta nel mito.
Innamoratisi del sound roccioso dei Led Zeppelin e complice la trovata di Jon Lord di filtrare il suo Hammond attraverso l’amplificatore Marshall di Ritchie Blackmore, in luogo del più canonico Leslie – “Avevo svegliato il mostro” ricorderà Lord – i Deep Purple cambiano coordinate verso un suono duro, anche più di quello di Page, Plant e soci, ma che si differenzia per un maggior gusto melodico e una minore dipendenza dagli stilemi blues, oltre che per le cavalcate dell’organo di Jon Lord.
Tuttavia, se è vero che “In Rock” centra il suono che definisce l’hard rock inglese e che darà la stura a decine di complessi che si mettono in scia, cambiando di poco gli ingredienti fino a creare l’heavy metal, è pure vero che quegli anni sono quanto di più frenetico si possa immaginare. All’indomani dell’immane successo di “In Rock” e del tour seguente, i discografici premono per avere un degno seguito; il tempo è poco e i ragazzi non vogliono essere ingabbiati solo in quel sound. Non è dato sapere quale di questi due motivi sia quello prevalente, il risultato è però “Fireball”, un disco che rimescola in parte le carte in tavola e che, pur vendendo bene, non ripete l’exploit dell’anno prima e delude i fan più duri e puri. Col successivo “Machine Head” avremo forse la quadratura del cerchio dei Deep Purple, con un suono talmente definito da avvicinarsi pericolosamente al cliché.

“Fireball” è invece un lavoro che, pur rientrando nei canoni del loro suono, si permette di sperimentare un po’ di più, cercando di allargare lo spettro sonoro del gruppo. Torna qualche accenno psichedelico, mescolato con quelli che sono i solchi più rock blues registrati fino ad allora – e sicuramente fino a “Burn” – mentre l’hard rock archetipico della band si fa sentire solo in alcuni brani, fino al paradosso di un passaggio al limite del country, di cui parleremo.
L’apertura all’epoca fece illudere i fan del suono più roccioso, offrendo un pezzo – quel “Fireball” che dà il titolo alla raccolta – che entra subito tra i più iconici della band. Introdotto da un break di batteria di Ian Paice che farà scuola, parte subito al massimo – in medias res, per così dire – con il canto rabbioso di Ian Gillan e un tappeto ritmico della chitarra di Ritchie Blackmore che sarà replicato fino alla nausea nel metal. Il bridge offre quegli squarci melodici che differenziano i Deep Purple da tante band epigone e spesso fanno la differenza, facendo da preludio agli assoli, piuttosto misurati, di Blackmore e Lord.
Il primo si produce in un suono quantomai saturo, il secondo sembra citare i momenti più ispirati di Ray Manzarek dei Doors. Con la successiva “No No No” la band inizia ad addentrarsi in territori quasi soul blues, con una chitarra quasi southern di Blackmore e un basso corposissimo di Glover, particolarmente in evidenza. La voce di Ian Gillan si esprime su toni particolarmente soul, con un falsetto assai scuro. La parte di chitarra di Blackmore, come spesso accade in “Fireball”, è insolitamente moderata e all’insegna di fraseggi blues, con un intermezzo più sperimentale e psichedelico che pare quasi un tributo a Jimi Hendrix. Nella seconda parte del pezzo – che a tratti sembra un po’ troppo lungo, come se non sapesse esattamente che direzione prendere – trova spazio un solo dell’organo di Lord, efficace e misurato ma non tale da entrare nel novero dei suoi migliori.
La terza traccia è “Demon’s Eye”, uno dei pezzi più smaccatamente debitori al blues dei Deep Purple, e forse il migliore tra questi. Dominato da un riff ossessivo della chitarra e del basso, offre l’ennesima grande prova di Gillan alla voce, efficace nel cambiare e adattare il suo particolare timbro ad ogni situazione. Jon Lord torna alla grande ai suoi livelli proponendo un assolo che insiste sulle note alte del suo organo e conduce mirabilmente le danze per quasi un minuto. Nella seconda parte, immancabile, arriva il solo di Blackmore; pur essendo estremamente riconoscibile, anche qui il suono è più pulito e misurato del solito, e i fraseggi sono di nuovo piuttosto inerenti alle scale blues: pare quasi che i Deep Purple, indecisi sulla linea da seguire, si rifugiassero in territori più sicuri, già esplorati tuttavia in lungo e in largo da Cream e Led Zeppelin prima di loro.
Occorre ricordare che la versione giapponese dell’album, riservata a un mercato particolarmente florido per la band, proponeva in luogo di “Demon’s Eye” la celebre “Strange Kind Of Woman”, già uscita come singolo e scartata all’ultimo momento; è uno dei momenti in cui i Deep Purple ritrovano le atmosfere a loro più consone: i riff insinuanti di Blackmore, il falsetto ululante alla Little Richard di Gillan, un bellissimo intermezzo melodico quasi beatlesiano e un assolo di chitarra in puro Blackmore style. Un peccato che alla fine il brano sia rimasto fuori dall’edizione ufficiale di “Fireball”, di cui, assieme alla title track, sarebbe forse stato il passaggio migliore.
“Anyone’s Daughter” è forse l’esperimento più curioso dell’intera discografia Deep Purple, un pezzo smaccatamente country, con Ian Gillan che pare un bizzarro incrocio tra Bob Dylan, Johnny Cash e Hank Williams. Lord si produce al piano in una parte che sembra uscire da un vecchio saloon, mentre la chitarra di Blackmore è degna di un episodio di “Hazzard”. Se volevano dimostrare la loro versatilità, i ragazzi inglesi ci riescono benissimo, con un bozzetto country quasi del tutto credibile; rimarrebbe da capire la pertinenza stilistica del brano che, pur apprezzabile e divertente in sé, rimane totalmente avulso dal contesto del disco e del canzoniere tutto del gruppo.
Ancora straniti, ci si ritrova nel mezzo di “The Mule”, cavalcata psichedelica sospesa tra il ritmo di Cream e Quicksilver Messenger Service e una parte vocale di Gillan – ampiamente filtrata – che pare echeggiare i Beatles più sperimentali. L’organo di Lord si produce in un solo altrettanto particolare, quasi un raga indiano – genere peraltro piuttosto in voga allora – per poi cedere il passo alla chitarra di Blackmore. Questa riporta il tutto alla concretezza, prima di riprendere a sua volta le atmosfere psichedeliche di Lord. Su “Made in Japan” la versione sarà arricchita da un interminabile assolo di batteria, allora usanza diffusa quanto temuta dagli spettatori.
“Fools” si apre dove “The Mule” aveva lasciato, ovvero su atmosfere composite e psichedeliche, con la chitarra di Blackmore che snocciola arpeggi ipnotici e la voce onirica di Gillan quasi salmodiante. Quasi due minuti e i Deep Purple improvvisamente si ricordano di essere la band che sta codificando l’hard rock: sui rocciosi power chord di Blackmore, la sezione ritmica si adegua e così Gillan che esplode in una parte vocale rabbiosa come non mai. Il ritornello – in verità molto bello ed epico – offre la chitarra a doppiare le parti vocali, prima che un crescendo quasi rumoristico riporti tutto alla calma iniziale. Qui Blackmore mena le danze pigramente per un paio di minuti, con una chitarra che sembra arrivare dal mondo dei sogni, prima che Gillan si riprenda la scena col suo urlo rabbioso. Un brano che troverà estimatori quasi replicanti nei Kula Shaker, band di buon successo alle stesse latitudine ma quasi trent’anni dopo. Tutto sommato un pezzo davvero interessante e ingiustamente poco celebrato nel repertorio di Gillan e soci.
C’è ancora spazio per “No One Came” in chiusura e, così come si era aperto all’insegna dell’hard rock più consono, “Fireball” si chiude. Non è certo il più memorabile tra i classici dei Deep Purple, ma il brano si fa ascoltare con piacere e contiene tutti quelli che diverranno i cliché del gruppo: i riff granitici di Blackmore e il suo assolo tutto giocato sulla leva del vibrato, il canto roccioso di Gillan, che all’epoca aveva poco da invidiare anche a Robert Plant, e la lunga cavalcata d’organo di Lord, il tutto su un ipnotico bordone di basso di Glover e sulla batteria sempre nel giusto tiro di Paice.
Per rispondere alla domanda con cui abbiamo aperto, “Fireball” è sicuramente più un lavoro di transizione nella discografia Deep Purple, piuttosto che un vero capolavoro; eppure alcune sperimentazioni – il blues di “Demon’s Eye” e la bella “Fools” – lo rendono molto interessante per l’appassionato e causano quasi una punta di rimpianto per alcune atmosfere che la band di lì a poco abbandonerà del tutto, a favore di un sound più centrato ma forse meno vario.
Ma la storia dei Deep Purple sarà ancora lunghissima e fin troppo movimentata.