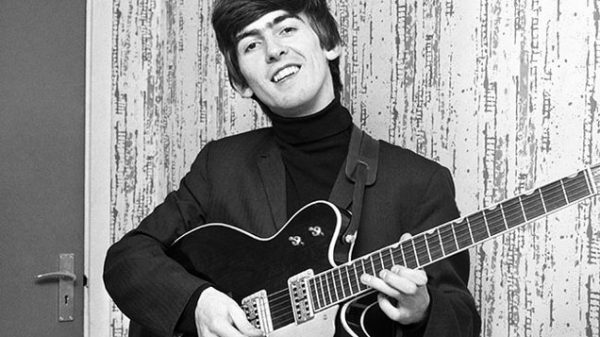Nella prima metà degli anni Sessanta, nella Londra che si avviava a meritarsi l’appellativo di “swingin”, Giorgio Gomelsky era un personaggio conosciuto in tutta la città.
Se lo ricordiamo ancora oggi, però, è soprattutto perché fu lui a coniare il soprannome “slowhand” per Eric Clapton. Gomelsky era una bizzarra figura, un po’ produttore e un po’ filmmaker, un po’ compositore e un po’ manager. Di origini georgiane e monegasche, in fuga dal regime sovietico visse tra Italia, Inghilterra e mezza Europa, venendo infine naturalizzato svizzero e per poi morire nel 2016 a New York. Una personalità multiforme, un girovago istrionico, tipica espressione del periodo più creativo del Novecento.
Leggenda vuole che, quando il giovane Clapton era il chitarrista più osannato di Londra, Gomelsky coniò il soprannome ispirandosi alla lentezza con cui Eric era solito sostituire le corde della sua chitarra; capitava spesso che, durante i live al Marquee coi suoi Yardbirds, Clapton, a causa dei suoi esasperati bending, rompesse qualche corda. Mentre il pubblico batteva a tempo le mani invocando il suo ritorno sul palco, Eric cambiava da solo la corda con compassata flemma. “Slowhand”, mano lenta, alludeva a quei momenti.
Tanti anni dopo, nel novembre del 1977, quello che ormai era diventato il secondo nome di Eric, dava il titolo a un suo album, quello che forse è rimasto più celebre della sua carriera solista. Sicuramente quello che, più degli altri, ne ha definito il nuovo stile, più rilassato e meno virtuosistico, all’insegna del suo celebre “laid back”.
Ma chi è Eric Clapton nel 1977, mentre nel mondo del rock si abbatte l’uragano del punk?
Sono passati dieci anni da quando, nel 1967, Clapton faceva faville sui palchi di mezzo mondo coi suoi Cream e con i sodali Ginger Baker e Jack Bruce; se per raccontare i primi anni di Eric, dal 1964 al 1970, ci vorrebbe un’enciclopedia, per tratteggiare i successivi basterebbe una parola: nulla. O quasi.
Già, perché dopo gli esordi con gli Yardbirds, abbandonati perché troppo inclini al commercio e poco al sacro verbo blues, Clapton attraversa il cielo del rock come la più sfavillante cometa. Incide con John Mayall il capolavoro del british blues, “Bluesbreakers”, riscrive le regole del rock coi Cream, dà vita quasi per incidente a due supergruppi che durano lo spazio di un’alba, i Blind Faith e i Derek and the Dominos, girovaga per gli States con Delaney & Bonnie e, all’inizio dei seventies, esordisce come solista.
Sono anni però di superattività e di eccessi: donne, droga, alcol e depressione, il chitarrista non si fa mancare nulla.
E quando arriva il riflusso a presentare il conto, le conseguenze sono tremende: dopo la stralunata esibizione al concerto per il Bangladesh organizzato dall’amico di una vita, George Harrison, Clapton sparisce fino al 1974. Quando riappare, con “461 Ocean Boulevard”, riprende là dove si era interrotto, con un rock rilassato ai limiti del country e del pop; è un suono quasi scioccante per chi lo aveva amato nei suoi dirompenti esordi, quando con la Gibson Les Paul dal suono saturo e distorto, aveva tracciato una via che perfino l’amico Jimi Hendrix aveva dovuto tenere in considerazione.
Il nuovo Clapton fatica a trovare un centro, uno stile convincente. Il rock si è evoluto con l’hard di Led Zeppelin e Black Sabbath e il progressive di tante band colte; il blues è quasi sparito dai palchi europei e la rivoluzione del punk è alle porte. Eric si rifugia in America, almeno musicalmente, studiando il suono di Tulsa del suo nuovo nume tutelare, lo sconosciuto J. J. Cale, già omaggiato con “After Midnight”, perla del suo esordio solistico.
Arriviamo così a “Slowhand”, un disco che nella temperie del periodo, tiene la barra diritta su un suono tradizionale e senza tempo, il suono che da allora contraddistinguerà l’Eric Clapton dei dischi in studio. Chi ha nostalgia delle sue galoppate chitarristiche deve accontentarsi – si fa per dire – dei suoi live, con versioni dilatate e grande spazio al blues, almeno fino agli anni Novanta e al sanguigno ritorno del guitar hero di “From the Cradle”.
È il momento di mettere sul piatto “Slowhand” e di sentire come suona dopo più di quarant’anni.
Il disco è prodotto da Glyn Johns, già al lavoro con Humble Pie, Rolling Stones e Led Zeppelin tra gli altri, ed è costituito da materiale misto: quattro cover e cinque pezzi originali composti dal solo Clapton o in collaborazione con altri musicisti. Dopo anni Eric vuole registrare in Gran Bretagna, agli Olympic Studios di Londra, per la precisione; la band, invece, è quella rodata negli ultimi dischi e tour: Carl Radle al basso, George Terry alla chitarra, Jamie Oldaker a batteria e percussioni, Dick Sims alle tastiere, Mel Collins al sax e Marcy Levy ai cori.
Il primo suono ad accoglierci è quello della chitarra nel robusto riff di “Cocaine”; nonostante la canzone sia una delle più celebri del canzoniere solista di Eric, si tratta di una cover. Era infatti appena l’anno prima, il 1976, quando “Cocaine” appariva in “Troubadour”, splendido album di J. J. Cale; ed è un rapporto di mutua dipendenza quello tra Cale e il Clapton solista. Negli anni Eric avrebbe saccheggiato il repertorio di J. J. ma anche lo stile rilassato e fatto di assoli il più possibile lontani dall’immaginario da eroe della chitarra, dando però di riflesso grande notorietà allo sconosciuto chitarrista di Tulsa, con cui divenne anche molto amico.
“Cocaine”, spesso scambiata per un inno alla droga, ne è al contrario un vero e proprio atto d’accusa, tuttavia in Argentina fu addirittura censurata dalla giunta militare al governo. Il riff, paradossalmente ricorda quello molto più duro e potente di “Sunshine of your Love” di dieci anni prima, periodo Cream, ed è emblematica la differenza tra i due pezzi: Clapton è passato dal furore psichedelico della band alla rilassatezza di un musicista plurimilionario e maturo.
Anche il nuovo stile, tuttavia, farà scuola, a partire dai Dire Straits, che lo ricalcheranno in parte già dall’anno successivo.
Si prosegue con un altro dei cavalli di battaglia del Clapton pop rock: “Wonderful Tonight”. Si tratta di una ballata soft rock dedicata alla compagna e poi moglie Pattie Boyd, quella stessa ragazza bionda che aveva già sposato George Harrison e che aveva messo a rischio una delle amicizie più solide della storia del rock.
È bizzarro pensare come la stessa Pattie si sia ritrovata a essere protagonista di due delle più belle canzoni d’amore della musica leggera: “Wonderful Tonight”, ma anche “Something” dei Beatles. La ballata venne composta in pochi minuti da Eric, innervosito dal ritardo di Pattie nel prepararsi per andare a una serata in onore di Buddy Holly organizzata da Paul McCartney; Clapton la scrisse e la dimenticò, deciso a cestinarla.
L’apprezzamento di Ronnie Wood, che la sentì eseguire chitarra e voce attorno a un falò, lo convinse a tenerla per il disco, e fece bene. “Wonderful Tonight” è a tutt’oggi uno dei pezzi più celebri di Eric Clapton.
“Lay Down Sally” è quanto di più vicino possibile al country e alla musica di Cale che Clapton riesca a comporre; a tal proposito “Slowhand” disse: “È il più vicino possibile allo stile country originale che io possa fare, essendo inglese, ma essendo la band originaria di Tulsa, Oklahoma, loro la suonano così naturalmente. Non potevi convincerli a fare un suono rock inglese, in nessun modo. La loro idea di un ritmo di guida non è forte o altro. È più sottile.”
Il pezzo, dal ritmo saltellante e coi cori country di Marcy Levy, va comunque via che è un piacere, completando un tris d’avvio che pone direttamente l’album nel novero dei migliori di Clapton. Il proseguimento, tuttavia, si rivelerà più altalenante.
“Next Time You See Her” è di nuovo una ballata in stile country, dai toni volutamente leggeri e con la voce di Clapton arrochita dai tanti abusi. C’è tutto, compreso un assolo di chitarra abbastanza sfumato e timido, tuttavia i fan del Clapton prima maniera rimasero probabilmente perplessi di fronte alla trasformazione in rilassato bardo country.
“We’re All The Way”, scritta dal cantautore americano Don Williams, non spariglia certo le carte in tavola, anzi. Siamo sempre lì, una ballata ai limiti del country dai toni volutamente blandi, molto gradevole ma lontanissima dall’idea di qualsiasi furore rock.
La seconda facciata del vinile si apre con “The Core”, una sorta di versione più robusta di “Lay Down Sally”, con la voce di Eric che duetta con quella di Marcy Levy; un miscuglio di rock, country e soul che risulta gradevole ma non accende certo i cuori. Il lavoro della chitarra è quasi esclusivamente ritmico, con la parte solista appannaggio del sax e di una breve parte della sei corde; il critico musicale Robert Christgau si lamentò addirittura di come la maggior parte dei migliori assolo di chitarra sul disco fossero opera di George Terry.
La successiva “May You Never” è una cover di John Martyn, chitarrista acustico sopraffino, dalla tecnica strabiliante e sempre peculiare nelle sue composizioni. La versione di Clapton è velocizzata e propone un arrangiamento più canonico. Si tratta sempre di una ballata riuscita, ma va detto che l’originale di Martyn è ben altra cosa. Il trattamento “normalizzante” di Clapton non giova alla canzone, che perde gran parte della sua originalità.
Quasi in extremis, Eric torna a fare quello che da sempre gli riesce meglio: il blues. E lo fa con “Mean Old Frisco”, uno standard di Arthur “Big Boy” Crudup, colosso di colore e bluesman degli anni Trenta e Quaranta, già malamente saccheggiato da Elvis Presley agli esordi. La versione di Clapton, guidata da una slide guitar spettacolare nella sua indolenza, omaggia a dovere il lavoro di Arthur, pur in una declinazione totalmente diversa dal folk blues d’origine. Un pezzo che riconcilia con lo stile votato al blues di Eric, uno stile che non abbandonerò mai del tutto, nemmeno nei bui e patinati anni Ottanta.
La chiusura dell’album è affidata a “Peaches and Diesel”, uno strumentale melodico con la consistenza dell’aria; spesso si trovano di questi brani nel canzoniere di “Slowhand”, a partire dalla celebre Layla, con la sua lunga coda strumentale all’insegna del soft rock. “Peaches and Diesel” riprende in parte la melodia di “Wonderful Tonight”, con un’indolenza melodica non priva di uno sghembo fascino quasi surreale.
Siamo alla fine di un album entrato nel mito, senza che forse si capisca bene perché; Clapton definisce le sue coordinate per i dischi successivi, a partire dal seguente “Backless”, quasi una copia carbone di “Slowhand”: atmosfere rilassate e rifiuto pressoché totale del ruolo di Dio della chitarra (Clapton is God docet). Un suono diverso ma che, almeno a livello di vendite, gli darà ragione; un suono che sancisce la definitiva uscita dal tempo – che era quello del punk, della disco e della new wave – di un musicista che si può permettere tutto.
Anche suonare diversamente da come i fan pretenderebbero.